Introduzione: la logica come base della ragione e della mente
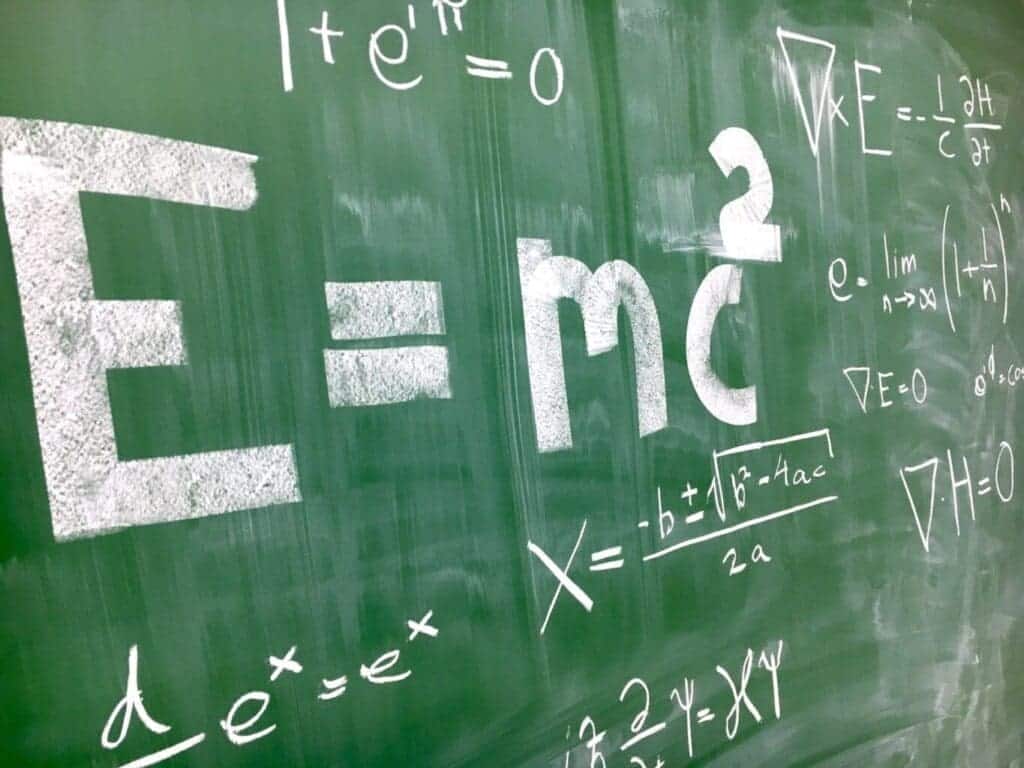
Per quanto creda nelle possibilità creative della genere umano, mi sembra assai dubbio che esseri privi di una predisposizione naturale al calcolo in senso generale possano raggiungere un simile traguardo e, soprattutto in un tempo così relativamente breve. Per questo motivo, cercherò, in questa sede, di esporre alcune considerazioni che nascono sia da molti recenti risultati in campo neuroscientifico, ma anche dalle necessità della moderna intelligenza artificiale, il cui compito principale non è più quello di elaborare algoritmi particolarmente efficienti (come il caso di molte tecniche di ordinamento e ricerca), ma di tentare la più importante sfida del nuovo millennio: vale a dire la riproduzione più o meno fedele dei meccanismi che stanno alla base del comportamento cosciente. Ad esempio, personaggi come Rodney Brooks del MIT o Mark Tilden del Los Alamos National Laboratory già da tempo hanno deciso di dirigere le loro ricerche robotiche verso un approccio che potremmo definire autopoietico, ovvero basato sulle capacità adattative che alcune particolari strutture (reti neurali e affini) possiedono, con l’intento di lasciare che sia la macchina ad apprendere tanto il modo con cui affrontare svariate situazioni reali quanto la rappresentazione più opportuna dell’ambiente circostante.
Sembra quasi che da un po’ di tempo a questa parte l’ingegneria dei sistemi intelligenti si stia dirigendo verso una sorta di “de-matematicalizzazione” dell’intero apparato teorico per lasciare il posto a metodologie la cui validità non è sempre garantita da teoremi più o meno elementari, ma piuttosto dalla fiducia che l’uomo ha nei mezzi che la natura ha impiegato per costruire, nel corso dell’evoluzione, il livello intellettivo umano attuale.
A questo punto, tuttavia, sorge spontanea una domanda: ma è realmente corretto affermare che l’uomo vive (in senso comportamentale) senza l’ausilio della matematica ? Cioè, in altri termini, lo sviluppo della matematica si deve all’opera creativa del genere umano, oppure essa, come lo studio delle leggi naturali, non è altro che una ragionevole presa di coscienza di una realtà in un certo senso autonoma? Per cercare di dare una risposta a questa domanda è necessario fare un breve ragionamento che verrà poi analizzato nelle sue parti essenziali nei capitoli successivi.
E’ evidente che molti dei risultati matematici più complessi non trovino alcuna applicazione nella vita di tutti i giorni, ma è altrettanto vero che valutare l’utilità di una conquista così importante partendo dalla situazione odierna è estremamente rischioso; esattamente come è assurdo tentare di comprendere l’arte moderna senza prima aver studiato attentamente il cammino di sviluppo che ha segnato la storia dell’uomo.
Oltretutto, ragionando in questo modo, si arriva al punto assurdo di considerare inutile anche l’estensione di concetti aritmetici elementari come addizioni o moltiplicazioni a numeri in cui molto difficilmente ci si può imbattere: se infatti 3 x 2 è un’operazione alla portata di tutti, ciò non è assolutamente vero se si sostituiscono gli operandi interi con valori leggermente diversi, come ad esempio 2.9999 x 2.0001. Eppure il passo logico più immediato, dopo la definizione rigorosa dell’insieme dei numeri naturali, è proprio quello di considerare quantità non intere la cui precisione può essere resa grande a piacere.
Se si comprende che la metà di 1 è un mezzo e si adotta la notazione standard 0.5, nessuno vieta di suddividere ulteriormente questo valore e non è possibile in alcun modo trovare un qualche risultato logico matematico che vieti l’iterazione senza fine; cercare di dimostrare quanto affermato è del tutto superfluo, ma tentare di comprendere perché la ragione ci porti verso una data direzione è un obiettivo tutt’altro che banale e necessita di un’analisi attenta e accurata di molti aspetti del pensiero matematico che vanno ben oltre i confini della disciplina stessa.
E’ innanzi tutto importante premettere che la base fondamentale di questa scienza è la logica e il primo uomo a dedicare molte ricerche in questa direzione è stato Aristotele, il cui obiettivo in questo particolare campo del sapere fu quello di definire una sorta di linguaggio astratto che fosse completamente svincolato dai concetti materiali.
Il dominio quindi passava dalla pura esperienza soggettiva alla ragione, che doveva naturalmente essere non soltanto oggettiva, ma anche universalmente valida. Partendo da questo presupposto egli analizzò il concetto di proposizione – che noi in questa sede tratteremo esclusivamente come appartenenza ad un certo insieme – e arrivò al fondamentale risultato che è possibile, in associazione ad ogni proposizione, definire una funzione di verità il cui risultato è sempre un valore di un insieme binario: ad esempio, se A fa parte di B l’affermazione è vera e quindi la funzione darà esito positivo, altrimenti sarà falsa. In effetti non è necessario accertarsi che le due condizioni siano mutuamente esclusive poiché è sempre possibile immaginare una suddivisione dell’universo di discorso (ovvero la totalità dei concetti compatibili presi in esame) in due parti complementari e collocare qualsiasi oggetto in una delle due senza indecisioni né ambiguità. Di conseguenza, ogni proposizione può ammettere (come risultato della funzione di decisione) solo due valori (vero o falso) e sono escluse tutte le altre possibilità (Principio del terzo escluso). Se è vero che A fa parte di B, automaticamente possiamo affermare che è falso il contrario, inoltre, la nostra ragione, ci porta ad eliminare ogni possibilità combinatoria: una proposizione non può essere vera e falsa contemporaneamente.
Come vedremo nella terza parte di questa trattazione, qualche decennio fa è nata e si è sviluppata, per opera del professore Lotfi Zadeh dell’Università di Berkeley, una nuova concezione della logica (detta “fuzzy”) che parte proprio dal postulare la non validità del principio del terzo escluso, anche se, in effetti, il presupposto in questione non viene in realtà eliminato del tutto, ma soltanto adattato alle esigenze speculative dell’uomo.
E’ chiaro che, se la questione è ben posta, non si può contemplare la bivalenza ma, con opportune strategie, è possibile “scomporre” la suddivisione binaria in svariate divisioni parziali e trattare ognuna di questa con una funzione di decisione non più del tipo vero/falso, ma capace di fornire un valore che rappresenta il grado di appartenenza al particolare insieme.
Sicuramente molti conoscono questa metodologia con l’esempio del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e, in effetti, senza opportune chiarificazioni si è portati a pensare che in alcune situazioni il ricorso al principio del terzo escluso sia del tutto fuori luogo: l’affermazione “il bicchiere appartiene all’insieme dei bicchieri mezzi pieni” non implica che il suo contrario (“ il bicchiere non appartiene all’insieme dei bicchieri mezzi pieni”) sia falso perché nessuno oserebbe dubitare del fatto che il bicchiere è anche mezzo vuoto.
In realtà questa è una vera e propria illusione mentale, dovuta al fatto che nella vita di ogni giorno difficilmente ci si trova in situazioni che richiedono la definizione di un problema in termini rigorosamente matematici: la questione precedente è binaria solo se la si rende “compatibile” con il pensiero logico, ovvero se si definiscono gli insiemi in modo tale che ogni dubbio viene sostituito da una certezza; ciò è sempre possibile in quanto l’appartenenza ad un dato insieme, in questo caso, è determinata da una grandezza puntuale, il livello del liquido contenuto nel bicchiere; se ammettiamo che esista un limite inferiore (0) ed uno superiore (l’altezza oltre la quale avviene il traboccamento), l’intervallo di variazione può venire diviso in due parti uguali e la proposizione “il bicchiere è mezzo pieno/vuoto” corrisponde esattamente al valore mediano del livello.
A questo punto è fondamentale rendersi conto che quando si riempie il bicchiere sino a raggiungere la soglia di separazione delle due parti si perviene ad una condizione univoca alla quale noi possiamo (e dobbiamo) far corrispondere uno ed un solo concetto linguistico, definito a meno di sinonimi: se, ad esempio, scegliamo la frase “mezzo pieno” e supponiamo che “mezzo vuoto” sia anche accettabile siamo costretti anche a dire che le due espressioni sono logicamente uguali e quindi non ha senso chiedersi se la validità dell’una implica quella dell’altra, poiché ciò è garantito dalla definizione stessa. In termini matematici la questione è molto più banale e può essere risolta eliminando del tutto le definizioni equivalenti logicamente: ciò che conta è il grado intensivo, ovvero il livello del liquido che può assumere tutti i valori reali compresi tra il minino e il massimo e, ogni volta che esso è uguale ad L, l’unica proposizione vera è “il bicchiere appartiene agli insiemi di tutti i bicchieri identici riempiti sino ad un livello L”, tutte le altre possibilità sono escluse.
La logica aristotelica è dicotomica e ammette soltanto ragionamenti che si rifanno ad un analisi dei concetti il cui esito non può essere diverso dai rigorosi vero/falso; tuttavia, in luce della molteplicità (anche solo funzionale) che implica la logica fuzzy, dire che il filosofo greco ha “semplificato” le sue indagini utilizzando questo stratagemma è non soltanto un errore grossolano, ma una vera e propria illazione negata dalla stessa esperienza umana. Si potrebbe perfino postulare che il pensiero dialettico è una realtà legata alla forma mentis di ogni uomo e ciò viene corroborato sia dai numerosi risultati raggiunti dalle scienze sperimentali (che si basano sulla logica aristotelica), ma soprattutto dall’innata tendenza a pensare sempre in modo complementare; è immediato rendersi conto che qualsivoglia idea (sia materiale che astratta) non può essere concepita senza aver prima tacitamente accettato il suo opposto. E’ probabilmente questo il motivo che ha spinto Aristotele verso la scelta del risultato binario, non una sterile concezione del mondo, ma piuttosto una profonda analisi psicologica della mente.
Ma qual è il punto di vista delle neuroscienze in proposito ?
Anche se ciò potrebbe sembrare alquanto strano, è stato dimostrato (vedi [1]) che la rappresentazione mentale dei numeri segue un andamento generalmente rettilineo, chiamato LNM – Linea Mentale Numerica – dal ricercatore Francis Galton a cui si deve questa scoperta, ed inoltre, come Umiltà e Zorzi hanno fatto notare, è sbagliato pensare che la computazione numerica avvenga attraverso gli stessi centri cerebrali deputati alle operazioni linguistiche. In altre parole, l’uomo ha maturato nel corso dell’evoluzione, una capacità autonoma di gestire le questioni matematiche e solo nei casi più banali egli fa riferimento a formule memorizzate con un basso grado di criticità, ad esempio i risultati della tavola pitagorica.
Ogniqualvolta ci si trova di fronte alla necessità di dover calcolare un risultato esistono due alternative: la prima è quella dell’approssimazione che, stando ai risultati di brain imaging, è assegnata all’emisfero destro, mentre la seconda è quella della precisione, intesa come analisi logico-razionale di problemi non immediati, che è svolta primariamente dall’emisfero sinistro.
Questa separazione di ruoli dimostra come l’elaborazione di informazioni da parte del cervello è preceduta da un intervento selettivo che dirige i flussi verso le direzioni più opportune e quindi, nel nostro caso, la particolare natura del calcolo matematico è “riconosciuta” a priori e non scaturisce da una sorta di “abuso linguistico”. Ma il fatto più interessante che conferma quanto affermato in precedenza è che la LMN è intrinsecamente una rappresentazione bisecabile.
Esiste quindi una conferma neuroscientifica riguardo all’ipotesi – più che ragionevole – che la mente umana non riesce a concepire l’indivisibile, nemmeno se si rifugia nelle più alte astrazioni della matematica; la logica dicotomica quindi non è una forzatura del pensiero, ma nasce proprio dalle caratteristiche struttural-funzionali dello stesso.
Un fatto particolarmente interessante, riportato in [1], riguarda un test durante il quale veniva chiesto ai soggetti di stabilire quale distanza tra coppie di numeri era maggiore; si è visto come i tempi di reazione erano molto più brevi quando le distanze erano grandi, mentre tendevano a crescere se i due numeri erano vicini. L’operazione di bisezione della LMN avviene correttamente (in soggetti sani) in entrambi i casi, ma quando si richiede una maggiore precisione, essa necessita di un elaborazione cerebrale più lunga e accurata; a questo punto nasce un dilemma: è possibile che il cervello abbia una visione “sfocata” del singolo punto della linea – il numero – e quindi, nei casi di maggiore vicinanza, si trovi in difficoltà nel fornire un risultato immediato ?
Ammettendo che questa ipotesi è possibile resta da capire perché un insieme (o successione) di numeri fornisca un’immagine mentale di un segmento, mentre l’elemento minimo viene defocalizzato e degenera in un’area di diffusione. Naturalmente quando si parla di LMN è sottinteso che ai soggetti intervistati viene chiesto di pensare ai numeri e non al numero, questa differenza, apparentemente sottile, è in realtà di fondamentale importanza in quanto permette di capire come il cervello generi ogni sequenza.
Qualora fossimo in grado di pensare al numero come entità autonoma e scorrelata ci troveremmo di fronte al paradosso dell’indivisibile: se infatti si accetta – non sulla base di disquisizioni filosofiche, ma piuttosto sull’esperienza di ogni uomo – che qualsiasi quantità debba poter essere suddivisa in quantità più piccole, si deve anche tenere presente che la LMN non potrà mai collassare in un singolo punto, tutt’al più essa può tendere verso un elemento atomico senza tuttavia riuscire a “scollegarlo” dai vicini. Di conseguenza, quando si tratta di dover decidere quale tra due intervalli è il più corto, è ragionevole supporre che, qualora gli estremi siano relativamente prossimi, da un punto di vista cerebrale avvenga una parziale sovrapposizione dalle areole che tende a confondere i due numeri rendendo maggiormente difficoltosa la loro discriminazione.
Questo effetto di “contaminazione” è , in un certo senso, analogo a quello relativo alla persistenza delle immagini sulla retina: la capacità di discriminare due fotogrammi risulta tanto minore quanto più essi sono vicini temporalmente; da un certo punto di vista la rappresentazione dei numeri è collegata al concetto di continuo che, a sua volta, è matematicamente associato al campo numerico reale. George Cantor ha dimostrato come questo insieme sia il più “denso” fino ad ora conosciuto e, a quanto pare, nessuno è ancora riuscito a dimostrare che esistano altri campi con una potenza del continuo maggiore.
Inoltre tutte le scienze sperimentali, in primo luogo la fisica, hanno costruito modelli dei fenomeni naturali che usano inevitabilmente numeri reali. D’altronde solo utilizzando questo campo numerico è possibile dimostrare che esiste una corrispondenza biunivoca con i punti di una retta e che quindi, anche la LMN è , in un certo senso, una rappresentazione locale dell’intero insieme. A partire da queste considerazioni si può concludere dicendo che non solo la logica è alla base di qualsiasi speculazione mentale, ma che il numero, nella sua accezione più metafisica, è concepito dalla mente umana come un concetto autonomo che permette di rappresentare un molteplice sequenzialmente ordinato.
La necessità linguistica della matematica
Il linguaggio naturale è una delle più importanti conquiste dell’uomo, esso si fonda sull’esperienza ed è fortemente legato al tipo di percezioni sensibili caratteristiche del genere umano; ad esempio, noi non “vediamo” un colore, ma semmai descriviamo l’effetto che una determinata lunghezza d’onda luminosa produce nel cervello attraverso un termine linguistico convenzionalmente designato per assolvere a quel particolare compito.
Una persona cieca dalla nascita non potrà comprendere cosa vuol dire rosso, verde o giallo, ovvero nella mente di quel tale individuo il processo di collegamento tra significante e significato non può avere luogo proprio perché l’elemento chiave mancante è l’esperienza. In questi termini il linguaggio comunemente utilizzato è limitato fortemente dalla sua stessa natura: esso è compreso entro i limiti che la definizione mentale a questo associata impone ed inoltre esso è sottoposto all’egemonia del tipo di sviluppo empirico di una data popolazione; il linguista francese Georges Mounin in [2] scrive: « …Ciò che il linguaggio comunica è la totalità dell’esperienza che noi abbiamo della realtà non linguistica (almeno potenzialmente), nella misura in cui essa è comune a tutti gli utenti di una lingua. …le lingue non analizzano questa realtà in modo identico e quindi esse non sono un calco invariabile, unico e sempre uguale, di una data realtà invariabile, vista sempre allo stesso modo in tutte le lingue; in breve, le lingue non sono nomenclature universali. ».
A pag. 63, l’autore mostra come alcuni idiomi africani abbiano un’enorme limitatezza nella descrizione dei colori, dovuta principalmente all’associazione di questi ultimi con la pigmentazione caratteristica della vegetazione; al contrario la lunga evoluzione storico-culturale europea ha portato alla definizione di innumerevoli varianti di una certa tonalità cromatica e ha trovato per ognuna di esse un termine adeguato ed univoco.
E’ chiaro quindi che ciò che noi ci ostiniamo a voler “chiamare” non è altro che il ricordo, più o meno vivido, di una data esperienza, la quale è il presupposto fondamentale di qualsiasi terminologia naturale. Ma si può parlare di un qualche tipo di esperienza nel caso dei numeri ?
Accettando questa ipotesi (che richiede una certa tolleranza !), la parola “numero” dovrebbe essere linguisticamente collegata ad una sorta di “percezione in senso lato” e, data l’universalità del linguaggio matematico, tale percezione non potrebbe in alcun modo essere influenzata dal particolare tipo di esperienza, ma piuttosto essa dovrebbe possedere un carattere di generalità in grado di oltrepassare ogni barriera sociale e culturale.
Per comprendere la ragionevolezza di quanto affermato è utile prendere in considerazione alcuni elementi strutturali del linguaggio naturale: il sostantivo, gli articoli, le congiunzioni, le preposizioni e alcuni verbi; naturalmente il mio ragionamento si riferisce in modo privilegiato alla lingua italiana, ma non è difficile riscontrare fortissime analogie funzionali con idiomi neolatini, anglosassoni e slavi. Nel caso, invece, di lingue arcaiche o legate a popolazioni poco evolute la situazione è leggermente più complessa a causa dell’utilizzo di paradigmi particolari basati, ad esempio, sulla polisintesi delle espressioni, tuttavia, come ha affermato il neuroscienziato A.Oliverio in [3], « …Ma perché mai, potremmo chiederci, tutte le lingue, pur avendo simili strutture, non si rassomigliano per gerarchia grammaticale ? Secondo Baker e numerosi linguisti della scuola di Chomsky, il linguaggio sarebbe evoluto anche come strategia per comunicare segretamente, per nascondere l’informazione ai competitori: e una differenza tra lingue avrebbe, anticamente, assolto a questa funzione “crittografica”. ». Alla luce di ciò è del tutto inutile preoccuparsi per le apparenti incompatibilità di traduzione, tenendo anche presente che il nostro obiettivo è quello di mostrare come siano il significato e la significazione, e non le regole sintattiche e grammaticali, ad avere una relazione profonda con la matematica.
Sarebbe contraddittorio supporre che alcuni popoli abbiano sviluppato una lingua filogeneticamente basata sul concetto di numero, mentre altri ne abbiano fatto a meno; è nostro obiettivo mostrare proprio come sia impossibile prescindere da esso e quindi, che il suddetto problema competa maggiormente all’ontologia. D’altronde, come fa notare Mounin, la ricchezza linguistica è determinata dal condizionamento ambientale e sociale, ma ciò non significa che un aborigeno australiano non sia in grado di istanziare gli oggetti della sua vita quotidiana semanticamente allo stesso modo di un europeo o di un americano. E’ questo il punto di forza che supporta pienamente la tesi della “percezione in senso lato del numero”, corroborata, a mio avviso, anche dalla fisiologia del sistema nervoso centrale e in particolare dalla staticità posizionale dell’area di Wernicke, deputata alla comprensione dei significati; in tutti gli esseri umani essa si trova nel medesimo punto e, in tutti gli esseri umani una lesione alla circonvoluzione temporale posteriore della corteccia cerebrale provoca un’afasia sensoriale.
Questo, anche se forse un po’ troppo riduzionista, mi porta alla domanda: Perché mai il cervello, presentando una struttura indipendente dal patrimonio genetico, dovrebbe dar vita ad un io cosciente funzionalmente diverso ? E’ più che evidente che io sostengo l’ipotesi che la natura tende verso una sempre crescente economia di mezzi, con l’obiettivo di eliminare le ridondanze (ad esempio la “potatura” delle sinapsi durante i primi anni dell’infanzia) e conseguire un’ottimizzazione degli elementi deputati al funzionamento dell’organismo.
Non ha alcun senso supporre che il prodotto dell’attività cerebrale dipenda solo in minima parte dall’architettura dei circuiti neurali ed è molto più logico e coerente pensare che, almeno macroscopicamente, il cervello – inteso come organo che attua le sue funzioni peculiari – sia un invariante del genere umano, allo stesso modo di ogni altro apparato e sistema che svolge tutte le funzioni vitali. Chi aborre la tesi del materialismo e considera il cuore o il fegato fondamentalmente differenti dal cervello potrebbe rifiutare a priori la mia posizione, tuttavia è bene precisare che la scienza deve procedere sulla base di ipotesi che siano in accordo con l’esperienza, partendo dalla condizione sine qua non che esse possono venire confutate in qualsiasi momento da nuovi sviluppi del sapere umano; lo scopo del riduzionismo è quindi quello di mantenere un continuum tra le conoscenze acquisite e assodate e gli ambiti ancora misteriosi del cervello e della mente. Chiarito il mio punto di vista passiamo all’analisi dei singoli elementi linguistici presi in esame facendo riferimento alle definizioni rigorose fornite dal Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana ®:
-
- Il Sostantivo
Esso è l’elemento fondamentale di qualsiasi linguaggio naturale, il suo ruolo è quello di fornire una rappresentazione fonico-grafica di un oggetto sia materiale che astratto. Per comodità suddividiamo i sostantivi in due categorie distinte: i nomi generali e i nomi particolari, alla prima appartengono tutti i termini che non si riferiscono a nessun oggetto puntuale, mentre nella seconda seconda sono contenute tutte le parole collegate a realtà ben precise ed univocamente determinate.
Il nome generale più comune è certamente “uomo”, esso trapassa qualsiasi barriera spazio-temporale e, definisce nel modo più globale l’intero genere umano, passato, presente e futuro; è possibile escludere questo nome dall’intero patrimonio linguistico per analizzarlo in un universo di discorso spoglio di ogni altro riferimento ? Anzitutto è ovvio che il soggetto di ogni esame è la persona che lo conduce, essa fa parte della categoria degli uomini e in sé racchiude ogni caratteristica peculiare del genere, è quindi ovvio che non si può certamente isolare il concetto se si desidera avere cognizione di esso.
Ma cosa accade nella mente di un individuo che si domanda cosa possa essere un uomo ? Il primo effetto è certamente quello di auto-riconoscimento: “Io sono un uomo”, il secondo, che in realtà è unificato logicamente al primo, è la rappresentazione mentale dell’idea di “uomo” in contrapposizione a tutte le altre possibili: “Io sono un uomo perché sono diverso da tutti gli oggetti che la mia mente può conoscere al di fuori dell’insieme degli uomini”.
E’ ovvio che in questa affermazione è racchiusa la tacita consapevolezza dell’esistenza di altre entità che hanno tutti i requisiti per poter essere classificati come uomini: il nome generale quindi è la rappresentazione sintetica di un insieme e, di conseguenza, esso deve attivare, a livello mentale, tutti i meccanismi associativi necessari per una definizione completa non del singolo elemento, ma piuttosto dell’intera classe da esso referenziata.
Chi si intende di matematica avrà certamente collegato la suddetta definizione con quella degli insiemi numerici e ciò non è certamente casuale, in quanto i due concetti non soltanto sono equivalenti, ma, da un punto di vista logico, il nome generale può esistere solo ed esclusivamente se se si definisce a priori un concetto “contenitore” capace di asservirsi a questo scopo.
Tale concetto è il numero, ovvero un’entità astratta, ma con un livello di generalità sufficiente a giustificare qualsivoglia corrispondenza tra insiemi materiali – costituiti da elementi che non siano numeri – e un opportuno sottoinsieme di un’opportuna classe numerica. D’altronde ciò che rende veramente interessante l’analisi dei nomi generali è la capacità della mente umana di costruire casi particolari in grado di suscitare la giusta consapevolezza: Kant definì questo processo sintesi figurata e, a mio parere, aprì le porte verso una più razionale comprensione del pensiero cosciente.
Se si chiede ad un individuo di pensare ad una strada è ovvio che si stanno fornendo tutti gli elementi necessari per attivare i processi cerebrali, ma non si sta definendo alcun caso particolare: ogni persona penserà a strade diverse, più o meno ricorrenti nell’esperienza, ma non esiste alcuna regola generale per determinare a priori quale immagine mentale verrà evocata. Inoltre non è assolutamente certo che il ricordo sia reale: è possibile che un individuo modelli una strada sulla base della sua fantasia o, per meglio dire, sulla enorme capacità di generalizzazione della mente.
In termini logici questo processo è perfettamente analogo a quello che avviene quando viene chiesto di pensare ad un numero e, anche se il paragone sembra sottintendere un maggiore “sterilità” in quest’ultimo caso, è bene ricordare che la quantità di informazione associata ad un qualsiasi ricordo è sempre finita e limitata, mentre i campi numerici – per comodità pensiamo a quello reale – non hanno alcun limite, né inferiore, né superiore. In altre parole, rifacendoci all’importantissimo risultato di Cantor, la sintesi di un numero reale è certamente la più “libera” tra tutte quelle possibili.
Naturalmente è molto più probabile che una persona si convinca di “possedere” (nel senso di capacità sintetica) molti più ricordi della vita quotidiana che numeri, ma ciò non significa che l’uomo ha sostituito gli oggetti percettivi con l’astrazione matematica per eccellenza, semmai questa constatazione ci dovrebbe far capire che la potenza generalizzante del numero è assolutamente infinita, al punto da “auto-incorporarsi” in qualsiasi rappresentazione mentale.
Per i nomi particolari il discorso è molto più semplice in quanto essi, da un punto di vista semantico, non devono attivare alcuna sintesi: il contenuto del termine bypassa tutti i circuiti generalizzanti per attivare direttamente le aree mnemoniche che contengono l’informazione puntuale.
Se tale processo non può avvenire poiché il ricordo è stato completamente obliato si attivano i circuiti neurali che fanno nascere la consapevolezza della non conoscenza. In termini matematici ciò equivale a cercare un particolare elemento in un dato insieme e l’esito può essere solo binario. Anche in questo caso è facile che nascano dubbi riguardo ad un’affermazione tanto forte, ma per quanto detto prima, ricordo che scegliendo opportunamente l’insieme (ampliandolo o restringendolo se necessario) qualsiasi dubbio sulla possibile bivalenza di un concetto viene automaticamente fugato.
In ogni caso, per i nostri scopi, non è essenziale accettare la dicotomia, quello che conta veramente è la progressione logica che dal numero generale perviene al particolare, ovvero il processo che permette di distinguere ad esempio Mario Bianchi dall’elemento “uomo”; è chiaro che Mario Bianchi è un uomo, ovvero appartiene all’insieme degli uomini, ma non è vero che un uomo è Mario Bianchi.
Ciò significa che “Mario Bianchi” non è in grado, come caso particolare, di rappresentare l’intera classe a cui appartiene in quanto non possiede tutte le caratteristiche necessarie. Il nome particolare è un nome generale privato dell’attributo di generalità, e di conseguenza segue sempre da quest’ultimo. Ecco quindi la risposta alla domanda sulla genesi dei concetti linguistici in seguito all’isolamento di un elemento: ciò non è possibile e per quanto ci si sforzi si ottiene un risultato che tende, come per la LMN, alla defocalizzazione del concetto all’interno dell’insieme di appartenenza senza tuttavia riuscire ad eliminare completamente i vincoli di legame imposti dal nome generale.
In sintesi possiamo dire che un nome particolare è analogo ad un numero ben preciso appartenente ad un insieme, e, dato che la cognizione umana dei numeri si riferisce sempre all’insieme (visto ad esempio come successione e rappresentato con la LMN) e non all’elemento puntuale, possiamo affermare che la nostra mente deve prima “impossessarsi” di un nome generale per poi, essere in grado di istanziare il caso particolare.
-
- Gli articoli
Per ovvie ragioni la mia discussione sarà incentrata sugli articoli indeterminativi (un, uno, una, tutti) che, ad esempio nella lingua italiana, hanno una corrispondenza immediata con il mondo dei numeri. “Una strada” è un concetto perfettamente equivalente al nome generale “Strada” allo stesso modo di “Tutte le strade”, tuttavia le due affermazioni hanno una collocazione logica molto diversa: nel primo caso l’indeterminazione lascia spazio alla sintesi figurata, mentre nel secondo caso viene chiamato in causa l’intero insieme, non come gruppo di caratteristiche, ma come entità autonoma che definisce una classe con peculiarità particolari.
Per capire quanto detto basta confrontare le frasi: “Pensa ad una strada” e “Pensa a tutte le strade”. La prima equivale ad invitare il soggetto a recuperare associativamente tutte le informazioni inerenti alla parola “strada” per poter poi sintetizzare un caso particolare idoneo, mentre la seconda, intesa in senso stretto, provoca inevitabilmente un paradosso, una sorta di “tilt mentale” poiché l’unico modo di pervenire ad un risultato sintetico è la deduzione quando, invece, l’articolo “tutte” richiede necessariamente un’induzione. Per poter risolvere il problema, il cervello, deve fare ricorso a tutte le sue risorse, senza tuttavia poter mai pervenire ad una soluzione accettabile.
Anche se ciò può apparire assurdo, la conoscenza iniziale ha bisogno delle classi per potersi definire “compiuta”, ma le costruzioni mentali che ne scaturiscono sono così potenti da non poter mai essere esplorate completamente, per questo motivo noi siamo portati a limitare l’universo di discorso e ad intendere la parola “tutti” non in senso assoluto – come sarebbe corretto -, ma in senso strettamente relativo. Se invece ci si riferisce impropriamente alle caratteristiche comuni a tutti gli elementi di un insieme la frase andrebbe intesa come: “Pensa a tutte le peculiarità che l’elemento generico appartenente alla classe delle strade deve possedere” che è perfettamente equivalente a: “Pensa ad una strada”. Naturalmente l’equivalenza sussiste in virtù del materiale informativo necessario per portare a termine la sintesi figurata, da un punto di vista puramente semantico le due affermazioni possono tranquillamente essere considerate diverse anche se per poter operare una qualunque significazione si deve comunque poter fare ricorso alla sintesi e quindi non all’elemento particolare in quanto tale, ma alle caratteristiche di appartenenza che in esso sono codificate.
L’articolo determinativo può venire utilizzato sia come semplice “apposizione” per nomi particolari, oppure, come spesso accade, per trasformare un nome generale – inteso come insieme di caratteristiche – nella classe corrispondente, esattamente come per l’articolo indeterminativo “tutti”. In generale il primo caso si verifica sempre quando si aggiunge alla frase una specificazione in senso lato: “La strada dove abito”, “Il fratello di Maria”, etc., mentre il secondo può essere sottinteso in frasi del tipo: “L’uomo è un’animale bipede”.
E’ ovvio che l’aggiunta della caratteristica “animale bipede” è possibile solo se viene definita a priori una categoria ben precisa (“L’uomo”) che raccoglie a sé tutti gli elementi aventi determinate peculiarità.
In sintesi: l’articolo indeterminativo (procedendo per analogie) è utile, ma non necessario per puntare al generico elemento numerico (un, uno, una) o all’intera classe (tutti), mentre l’articolo determinativo può assumere due valenze, la prima è del tutto equivalente all’ultimo caso indeterminativo, la seconda, congiuntamente ad una specificazione, permette di puntare ad un particolare elemento di un insieme.
-
- Le congiunzioni
Le congiunzioni (noi ci limiteremo a prendere in considerazione solo “e” e “o”) sono, per eccellenza, connettivi logici che trovano nell’algebra booleana una precisa e importantissima collocazione. Consideriamo le proposizioni: “A e B sono C” e “A o B è C”: la prima esprime il concetto di appartenenza di A e B all’insieme C e quindi, se C è definito attraverso una collezione di caratteristiche, essa afferma che sia A che B possiedono le peculiarità necessarie per essere membri di C.
La sintesi figurata di C (a partire dalla conoscenza della suddetta proposizione) potrebbe quindi propendere verso A o B (o un miscuglio delle due) senza alcuna regola ben determinata; per esempio, chiedendo ad un uomo bianco di pensare ad “un uomo”, è molto probabile che l’esperienza quotidiana lo porterà ad immaginare sinteticamente un bianco, mentre la stessa richiesta fatta ad un asiatico potrebbe culminare nella rappresentazione mentale di una persona con gli occhi a mandorla e tutte le altre caratteristiche fisiche degli asiatici.
Tuttavia ciò non implica che i risultati possano tranquillamente essere invertiti, poiché quello che conta realmente è il fatto che A e B sono entrambi elementi di C. La congiunzione “e” permette quindi di raggruppare proposizioni equivalenti per caratteristiche di appartenenza in modo da semplificarne la forma, ma ovviamente se ne potrebbe fare a meno a patto di “scorporare” tutte le sotto-frasi di una data affermazione: “A e B e C e … e Z sono W” equivale all’unione di: “A è W”, “B è W”, … , “Z è W”.
La congiunzione “o”, al contrario, è mutuamente esclusiva e trova un valido impiego in tutte le proposizioni in cui esiste un dubbio di appartenenza; è da notare che, mentre “A e B sono C” aumenta il livello di informazione globale a cui contribuisce ogni singola sottofrase, “A o B è C” ci garantisce solo che uno dei due elementi è peculiarmente idoneo a far parte di C, ma non ci dà alcun indizio utile riguardo all’altro. L’unica certezza logica che abbiamo è che se per esempio A appartiene a C, B non gli apparterrà sicuramente, tuttavia il connettivo “o” non è in grado di fornirci dati adeguati per venire a conoscenza della sua collocazione. Bisogna infatti tenere presente che per validare una proposizione con la congiunzione “o” non è assolutamente necessario essere consapevoli delle caratteristiche di entrambi i membri: la frase “Albert Einstein o “gklikj” era un uomo” è corretta, ma noi arriviamo a questa certezza pur non avendo idea di cosa possa essere un “gklikj”.
La sintesi figurata a partire dal connettivo “o” si basa solo ed esclusivamente su uno solo dei due elementi e non può, in genere, pervenire ad un’immagine ragionevole dell’altro, l’unico caso in cui ciò è possibile è quando l’esclusione avviene tra oggetti conosciuti e perfettamente classificati; in tal caso, da un punto di vista logico, si verifica una sorta di “separazione coattiva” delle sotto-frasi che ha come risultato l’eliminazione della ridondanza dovuta all’uso del connettivo.
Per esempio: se io affermo che “Mia madre o il mio cagnolino è un uomo” ciò che implicitamente opero equivale alla disgiunzione delle due proposizioni: “Mia madre è un uomo” – Frase logicamente corretta – e “Il mio cagnolino non è un uomo”, che viene immediatamente mutata in: “Il mio cagnolino è un elemento dell’insieme dei cani”.
Linguisticamente, quindi, le congiunzioni hanno un ruolo fondamentale nel linguaggio naturale, ma la loro “potenza” semantica scaturisce soltanto dalla logica che, grazie alla razionalizzazione del pensiero e delle espressioni, si fa garante non soltanto del loro corretto utilizzo, ma anche dei risultati mentali che da esse scaturiscono. Comunque per chi volesse approfondire l’argomento suggerisco di consultare un testo di logica in cui vengono messi in evidenza tutti i risultati speculativi più evoluti.
-
- Le preposizioni
Riferendoci alla lingua italiana esistono 9 preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) che hanno il ruolo linguistico di permettere la formazione dei complementi.
Come abbiamo detto prima nel caso degli articoli indeterminativi, molto spesso i nomi particolari vengono ottenuti a partire da un nome generale seguito da una specificazione, ad esempio la frase “Gli uomini di Roma” è composta da un riferimento alla classe “uomo” e da un’opportuna aggiunta, “di Roma”, che limita l’insieme di possibili valori.
Il ruolo dei complementi è quindi quello di permettere la definizione di sottoclassi generate dall’insieme di caratteristiche relative ad una classe “madre” e dalle condizioni imposte dall’analisi; anche in questo caso la logica è l’unica garanzia di successo poiché, al fine di costruire proposizioni corrette, è necessario che le condizioni specificate dal complemento non siano in disaccordo con le caratteristiche peculiari dell’insieme. Per potere quindi validare una siffatta proposizione è impossibile non fare ricorso ad una sintesi figurata condizionata che però è molto più debole di una normale sintesi in quanto la sua riuscita dipende non solo dalla ragione, ma anche dall’esperienza. Come al solito consideriamo un esperimento virtuale e valutiamo la reazione di un soggetto a cui viene chiesto di pensare ad “un uomo di Marte”; è ovvio che la sintesi figurata condizionata è soggetta alla conoscenza della regola tutt’altro che deterministica che sul pianeta Marte non ci sono uomini, infatti, pur ammettendo che una razza vivente su Marte abbia caratteristiche peculiari, ciò non vuol dire che non sia lecito per il cervello figurarsi un marziano con le fattezze di un terrestre.
In effetti la richiesta è mal posta in quanto in essa esiste il presupposto che se Marte è popolato, certamente ci saranno elementi classificabili come uomini; ben diversa è la questione se si chiede di pensare ad “un abitante del pianeta Marte”. In questo caso la sintesi può avere luogo solo se è stato predefinito un insieme opportuno di caratteristiche che la popolazione del pianeta rosso deve possedere; se ciò è stato effettuato, anche con la fantasia, è facile che vengano in mente immagini di piccoli uomini verdi con le antenne, ma se, al contrario, non si ha alcuna consapevolezza dell’esistenza di una simile classe allora la logica vieta di formulare proposizioni come l’ultima da noi presa ad esempio poiché altrimenti si corre il rischio di precipitare in un vortice di ambiguità e passare dal dominio della ragione a quello dei pareri soggettivi.
Dunque i complementi sono ammissibili solo se, grazie ad essi, è possibile portare a termine una sintesi figurata che si fondi sia sulla ragione che sull’esperienza, ma il loro uso indiscriminato è oggetto di monito della logica perché le condizioni che impongono alla proposizione non devono mai essere in disaccordo con le caratteristiche generatrici della classe presa in considerazione.
-
- I Verbi
La struttura fondamentale di una proposizione linguistica è: Soggetto – Predicato – Complementi. Per i nostri scopi partiremo dal presupposto che il verbo essere e i suoi sinonimi funzionali rappresentino gli elementi chiave di appartenenza ad una classe, per cui non ha senso discuterne ulteriormente.
Un caso particolare è quello relativo alla comparazione di nomi particolari, “A è B”; da un punto di vista logico esistono due alternative: la prima assume che A sia identicamente uguale a B perciò la proposizione è tautologica, mentre la seconda è il classico caso in cui B è un nome generale per cui ritorniamo al caso principale. Per quanto riguarda gli altri verbi essi generano proposizioni sempre riconducibili allo stereotipo “A appartiene all’insieme B”; la sintesi figurata di immagini mentali che nascono da frasi composte da soggetto e predicato è molto spesso legata all’esperienza personale e non è sempre facile poter operare delle opportune generalizzazioni, tuttavia è interessante notare come la mente è tendenzialmente portata a rifiutare i “vuoti”, essa si rifugia nell’immaginazione pura ogniqualvolta l’esperienza è assente o troppo limitata. Il risultato di ciò è la formazione di idee e convinzioni errate che talvolta purtroppo condizionano l’intera esistenza; la logica, che nasce dalla ragione, rifiuta qualsiasi elemento che non trovi una debita collocazione all’interno di un ragionamento razionale e quindi preserva l’utente da fallimenti auto-costruiti.
E’ chiaro che mantenere un controllo della propria vita basato esclusivamente sulla logica può apparire molto deludente (anche se essa rimane pur sempre la base di qualsiasi speculazione mentale) ma io sono convinto che il rispetto delle semplici regole dell’inferenza può garantire un migliore approccio a svariate situazioni in cui siamo spinti alla sintesi di realtà di cui non possiamo in alcun modo asserire la verità.
Il Fuzzy-pensiero e il concetto di probabilità
Quando il professor Lotfi Zadeh formulò la sua teoria sugli insiemi fuzzy egli partì dalla celebre considerazione che gli esseri umani sono in grado di prendere decisioni sulla base di informazioni in ingresso parziali e imprecise, per questo motivo la programmazione di sistemi automatici per la gestione di situazioni particolarmente complesse è molto più impegnativa dello svolgimento manuale delle stesse da parte di un operatore umano. In [4] Bart Kosko, il principale “seguace” della filosofia fuzzy, cita l’esempio del parcheggio di un autoveicolo in retromarcia; questo compito è svolto in modo assolutamente naturale dalla grande maggioranza degli automobilisti, ma richiede una modellizzazione matematica così complessa da rendere l’automazione del processo fuori dalla portata dei calcolatori di uso comune. Questa lacuna può essere colmata cercando di programmare i sistemi non seguendo la logica aristotelica ma piuttosto facendo riferimento a quella fuzzy.
In questa sede assumeremo che il lettore abbia una minima conoscenza dei principi fondamentali che stanno dietro a questo modo di affrontare la risoluzione di svariati problemi, tuttavia desidero ricordare che la base di tutto sta nel tipo di funzione di appartenenza ad un insieme che viene utilizzata. Nel caso dicotomico essa doveva necessariamente essere binaria, nel caso fuzzy, invece, essa fornisce un grado di membership continuo e variabile tra 0% e 100%. Secondo questo principio un elemento A può appartenere a differenti classi con la sola condizione che totalmente il grado non superi l’unità (100%); in un certo senso questo modo di ragionare è molto simile al concetto di probabilità e in questa sede cercherò di spiegarne i motivi.
Ogniqualvolta la nostra conoscenza della realtà non può raggiungere un livello soddisfacente, si è spesso portati – seguendo implicitamente gli insegnamenti del fisico-matematico Laplace – a rivolgersi verso un approccio (il probabilismo) che, pur permettendo di conoscere solo alcuni aspetti del problema, non lascia la nostra mente nell’ombra dell’ignoranza. Come dice Kosko in [4], « …Credo dunque che la probabilità o “casualità” sia un istinto psichico, un’archetipo junghiano o una propensione mentale che ci aiuta a organizzare le nostre percezioni, le memorie o la maggior parte delle nostre attese. La probabilità dà una struttura ordinata alle previsioni causali, tra di loro contrastanti, su come evolverà il futuro nel prossimo istante, stagione o millennio. ».
Ciò che noi definiamo “probabile” è in effetti a metà strada tra il “vero” e il “falso”, ma, a differenza di illazioni prive di qualsiasi fondamento, la probabilità si basa su ragionamenti logico-razionali e perviene a certezze assolutamente inequivocabili. Quando si dice che l’età media di una popolazione è di 35 anni, non si vuole lasciare intendere che tutti i membri del gruppo siano trentacinquenni, ma piuttosto che è logico considerare un valore numerico (la media) che ci informa, insieme alla varianza, sulla frequenza di incontri favorevoli con individui la cui età è relativamente vicina ad un valore desiderato.
La media e la varianza sono dati deterministici, l’approccio invece non lo è. Ma che rapporto sussiste tra probabilismo e fuzzificazione della logica ? Quando abbiamo parlato della LMN abbiamo visto che il concetto di numero appare intrinsecamente sfocato, esso genera non un punto, come la geometria analitica vorrebbe, ma piuttosto un’areola che si sovrappone ai tratti di linea adiacenti.
Questo processo scaturisce dall’esigenza di continuità del cervello e, in un certo senso, “affligge” l’uomo sin dalla sua comparsa sulla terra, tuttavia esso svela in modo abbastanza evidente ciò che Bart Kosko ha scritto nel suo magistrale saggio sulla logica fuzzy: l’uomo vede nella probabilità non un ricorso “di comodo”, ma piuttosto una necessità che trascende persino i confini della fisica.
A questo punto sembra evidente che quanto affermato sino adesso sia confutato dalla psicologia, ma in realtà il problema è ben diverso e richiede un’analisi attenta che non si limiti agli effetti ma cerchi piuttosto di raggiungere le cause. Innanzi tutto è bene dire che la logica fuzzy non è un’alternativa a quella aristotelica, ma semmai essa ci pone innanzi le questioni speculative da un punto di vista differente; dire che un elemento appartiene a più insiemi con un grado per ciascuno equivale a dire che esso può appartenere ai diversi insiemi, ma che effettivamente è sempre possibile e ragionevole supporre la bisezione dell’universo di discorso e la conseguente collocazione dell’elemento in una delle sue classi complementari. Questa operazione è comunque in genere abbastanza difficile da compiere in quanto presuppone una conoscenza globale del problema e non ammette alcuna approssimazione, in questo senso l’affermazione di Lotfi Zadeh è analoga all’invito di Laplace a far uso del calcolo delle probabilità ogniqualvolta le porzioni di natura in esame presentano una complessità tale da rendere impossibile qualsiasi altro approccio.
Però è anche ovvio che questa scelta non deve essere prioritaria a quella del determinismo, altrimenti si rischierebbe di ridurre sempre più il grado di conoscenza dell’uomo, sia nel caso delle scienze naturali, ma anche nell’ambito studiato dalla psicologia. La vita quotidiana non è facilmente gestibile facendo ricorso alle potenti tecniche matematiche usate in fisica o in ingegneria, ma non si può nemmeno dire che il nostro modo di ragionare prescinde dall’esigenza di precisione, anzi è semmai il desiderio di “possedere” i concetti nel modo più completo a spingerci verso un approccio apparentemente meno valido.
Poco sopra ho detto che la sintesi figurata di proposizioni di cui non si ha molta esperienza viene affrontata dal cervello operando una sorta di “improvvisazione” che utilizza i dati posseduti e cerca di prevedere quale possa essere il valore di una certa affermazione basandosi su costruzioni più o meno coerenti, ciò può essere letto in chiave “fuzzy”: a meno di non possedere alcuna informazione utile (il che rende impossibile qualsiasi approccio) la mente umana si rivolge inconsciamente al probabilismo e “inquadra” i dati in modo abbastanza sfocato (fuzzy = sfocato) ma sufficientemente preciso per dar vita ad immagini mentali soddisfacenti.
Ad esempio, un neonato non ha cognizione della differenza che sussiste tra l’avere fame e l’avere sete, ogni volta che il suo organismo segnala una carenza di glucosio o di acqua viene attivato il meccanismo di segnalazione del pianto; in seguito a ciò egli viene nutrito con il latte e, in questo modo, vengono soddisfatte entrambe le necessità.
E’ ovvio che la mente del bambino non può effettuare correttamente una dicotomia finché non raggiunge lo svezzamento e un livello di coscienza sufficiente, tuttavia egli sarà sempre in grado di figurarsi sinteticamente il significato delle frasi “Ho fame” e “Ho sete” anche senza informazioni precise. In qualche modo egli valuta la probabilità che una determinata sensazione abbia caratteristiche in comune con un’altra e opera una classificazione del tipo: “Provo un senso che assomiglia ad un elemento generico dell’insieme costituito da dalle sensazioni di fame, ma nello stesso tempo esso può essere membro dell’insieme costituito dalle sensazioni di sete”.
La logica fuzzy quindi permette gestire con più rigore tutte quelle situazioni che, pur obbedendo alla logica aristotelica, risultano di difficile comprensione e trattazione.
Riferimenti bibliografici
-
- C. Umiltà, M. Zorzi, I numeri in testa, Mente&Cervello n.2 Marzo-Aprile 2003
- G. Mounin, Guida alla Linguistica, Feltrinelli
- A. Oliverio, Prima Lezione di Neuroscienze, Editori Laterza
- B. Kosko, Il Fuzzy Pensiero, Baldini&Castoldi
- I. Kant, Critica della Ragion Pura, Editori Laterza

